Basic HTML Version
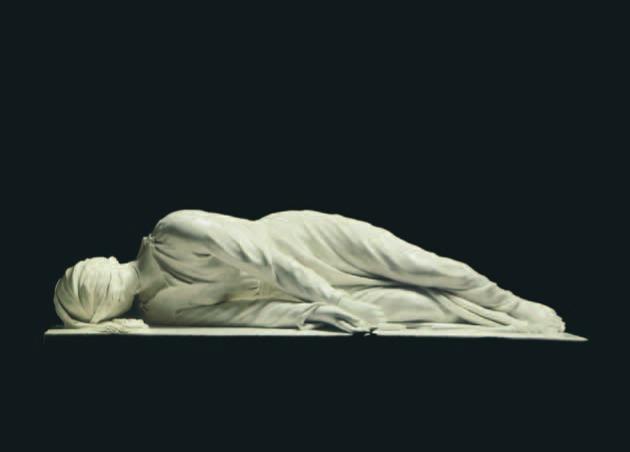
Il Seicento: tra naturalismo e ideale classico
402
La situazione a Roma
Una
nuova esigenza di naturalismo
viene progres-
sivamente a farsi strada tra le secche dell’ultima
stagione manierista. Uno scultore originario della
Lombardia, Stefano Maderno (Bissone, 1576 - Ro-
ma, 1636), è autore della
Santa Cecilia
(1)
. Nella fa-
se di passaggio dal tardomanierismo al Barocco, la
Santa Cecilia (restaurata nel 2001) è un’opera mol-
to significativa; non per nulla suscitò l’interesse di
Gian Lorenzo Bernini.
Stefano Maderno
la eseguì nel
1600
all’interno di un
monumentale altare di marmo e bronzo, commis-
sionato dal cardinale Sfondrati, con una sensibili-
tà che potremmo dire lirica e che gli derivava dal-
la statuaria alessandrina. Gli era stata ispirata dal
ritrovamento delle spoglie pressoché intatte del-
la giovane santa, morta martire nel III secolo e se-
polta nelle catacombe di San Callisto. Maderno la
raffigura dal vero nella posizione in cui fu trovata,
con il segno della decapitazione e un velo per rac-
cogliere il capo reciso, come si era soliti fare con i
condannati a morte, quasi si trattasse di un ritratto
postumo rivestito di intensissimo pathos. Una tale
fusione di realismo e idealizzazione preannuncia la
rinascita di un
linguaggio classicista
che a Roma si
affermerà solo venti anni più tardi.
Tra Cinque e Seicento il variegato panorama artistico
a
Roma
si può riassumere così: da un lato il persiste-
re del Manierismo, da un altro l’affermarsi di un ve-
rismo devozionale che sfrutta le potenzialità espres-
sive dell’ordine formale e scenografico di Raffaello
anticipando il realismo caravaggesco; da un altro an-
cora un originale ritorno alla classicità della pittura
di
Annibale Carracci
(pp. 406-410).
In Italia, all’inizio del Seicento, è proprio la linea
classicista a prevalere. Essa precede e supera, quan-
to a successi, il Barocco romano di cui si avvertono
le avvisaglie già negli anni Venti del secolo nell’ope-
ra del pittore Giovanni Lanfranco (p. 441).
Roma, l’Italia e l’Europa all’inizio del Seicento
Roma, l’Italia e l’Europa all’inizio del
Seicento
Da Sisto V a Clemente VIII
Sisto V aveva svolto una politica culturale tesa
a dimostrare che esisteva una continuità tra la
Roma antica e la Roma cristiana, splendida e
fe-
lix
. Clemente VIII, pur non essendo un pontefi-
ce “politico” nel senso stretto della parola, mise
a segno un successo diplomatico rilevantissimo:
Enrico IV di Navarra, re di Francia, abiurò la re-
ligione protestante, si convertì al cattolicesimo e
tornò a Roma nel 1595, per fare ammenda davanti
al papa. Tuttavia l’equilibrio del conciliante Cle-
mente VIII si era incrinato quando, nel febbraio
del 1600, il Santo Uffizio aveva mandato al rogo
Giordano Bruno
t
dietro l’accusa di eresia, dopo
un regolarissimo processo nel quale era stato fatto
il possibile per scongiurare il supplizio, in previ-
sione delle sconcertanti conseguenze che avrebbe
portato con sé. All’interno della Curia romana,
pur nella diversa matrice culturale dei cardina-
li, facoltosi committenti di opere d’arte, regnava
l’ammirazione incontrastata per Raffaello.
Per l’intero Cinquecento, ma specialmente nel-
la seconda metà del secolo,
Raffaello
rappresen-
ta infatti un
punto di riferimento
irrinunciabile.
Per esempio il Cavalier d’Arpino, pittore tar-
domanierista, aveva temperato la retorica delle
grandi composizioni ricorrendo all’ordine for-
male dei modelli raffaelleschi. La sua
Ascensio-
ne
(2)
in San Giovanni in Laterano, affrescata nel
1599 alla vigilia del Giubileo, ricorda, in modo
un po’ impacciato, la
Trasfigurazione
di Raffael-
lo in San Pietro.
Del “divino urbinate” si apprezzavano quelle carat-
teristiche che erano state raccomandate anche dalla
Controriforma: la perfezione formale, il decoro, la
“convenienza”
t
, la “facilità”
t
.
t
Giordano Bruno
nacque a Nola nel
1548 e morì arso vivo a Roma nel 1600.
Nel 1572 era stato ordinato domenicano
ma a meno di trent’anni gettò la veste
e tornò alla vita laica. Bruno percorse in
lungo e in largo l’Europa. Invitato dal nobile
Giovanni Mocenigo a Venezia, fu da questi
denunciato all’Inquisizione di Roma; rimase
in carcere otto anni prima del processo
e della condanna per eresia. Nelle sue
numerose opere filosofiche prende forma
un pensiero complesso, che consiste in un
fondamentale immanentismo che perviene a
conclusioni anche violentemente dissacranti.
t
facilità
si riferisce al contenuto delle
immagini sacre che devono poter essere
comprese dai fedeli con immediatezza, di
qui l’esigenza di una chiarezza espositiva
e di un’iconografia semplificata;
t
decoro
e
convenienza
sono concetti di
ordine morale trasferiti sul piano estetico:
si vuole che le immagini si pongano al
servizio della fede per istruire ed edificare
i fedeli, e a questo scopo l’immagine viene
sottoposta al controllo delle gerarchie
ecclesiastiche affinché non “offenda”
il senso delle Scritture e della dottrina
cristiana. Risponde al decoro anche il brutto
o la resa veristica dell’immagine quando
sia conveniente al messaggio cristiano.
1
Stefano Maderno,
Santa Ceci-
lia
, 1600, marmo. Roma, basilica
di Santa Cecilia in Trastevere.
1

