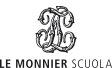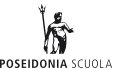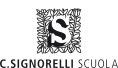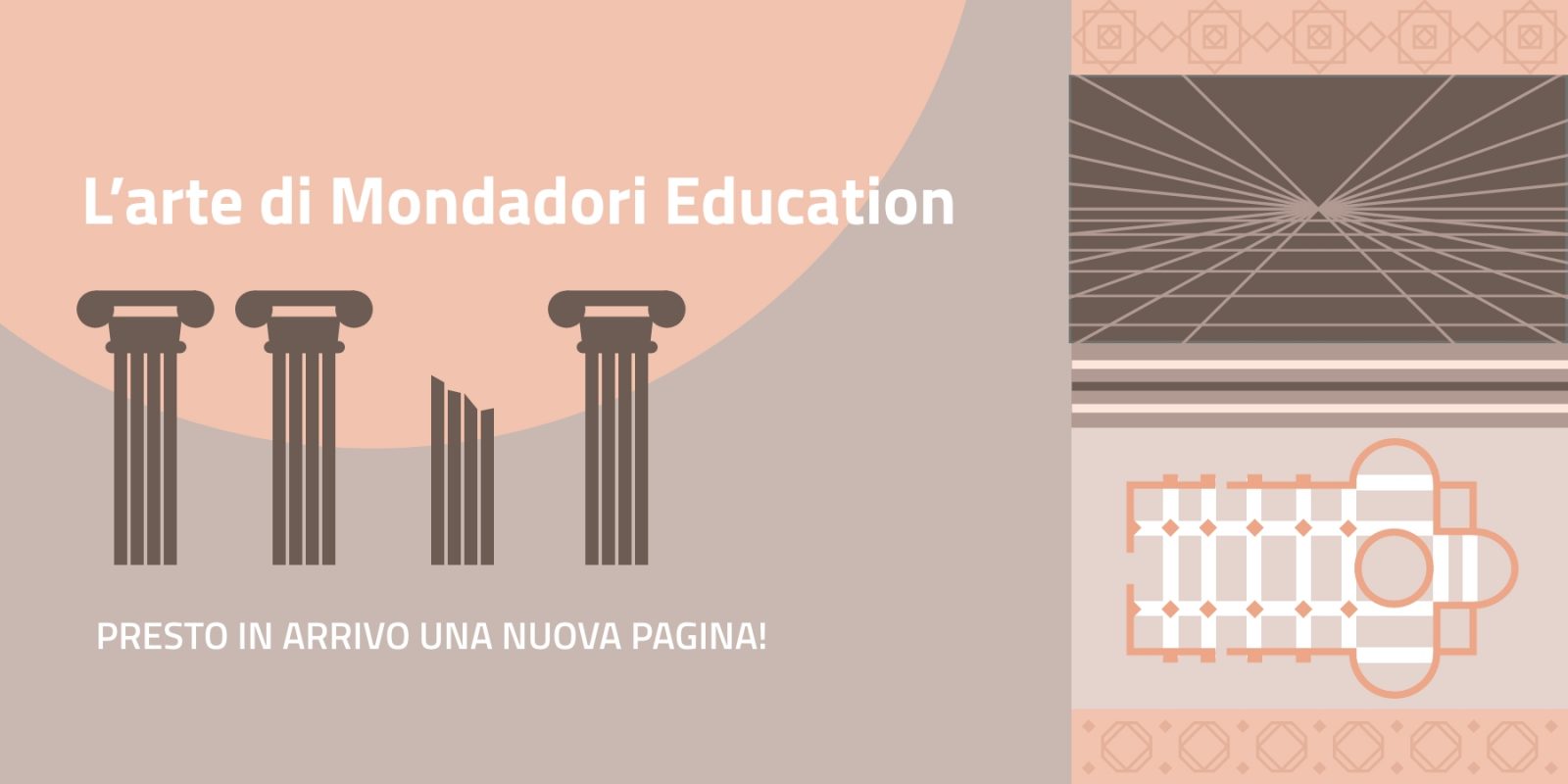
La Stele di Rosetta - 200 anni dalla decifrazione
Per festeggiare insieme questo (bizzarro) anniversario, l’articolo ripercorre brevemente la storia della Stele di Rosetta, dal suo accidentale ritrovamento alla tanto agognata decifrazione dei più misteriosi dei segni: i geroglifici!
Un ritrovamento fortuito
Il 19 luglio del 1799, mentre organizzavano alla bell’e meglio le difese, abbiamo la ragionevole certezza che i pensieri degli uomini di Pierre-François Bouchard fossero rivolti altrove: difficilmente sapevano che, di lì a poco, avrebbero scoperto la celeberrima Stele di Rosetta, una scura, sporca ed impolverata lastra di granodiorite destinata a cambiare il mondo.
Ma facciamo un passo indietro. Siamo nel pieno della campagna d’Egitto: dopo essere sbarcato ad Alessandria, Napoleone procede vittorioso fino ad Abukir, dove Horatio Nelson avrebbe distrutto la sua flotta (e con essa gran parte dei suoi sogni di gloria). Ed è proprio mentre tentano di riparare il forte di Rosetta, Fort Julien, nella speranza di difendersi dall’offensiva ottomana, che i soldati francesi scoprono un grosso frammento di pietra di circa 760 kg, inciso con misteriosi simboli.
Archeologi (quasi) per caso
Fu proprio a loro che il capitano Bouchard, incuriosito dal misterioso ritrovamento, si rivolse. La stele di Rosetta passò allora al generale Jacques François Menou, che decise di portarla ad Alessandria. Quando però nel 1801 giunse per i francesi il momento della resa, gli inglesi non si rivelarono particolarmente inclini a concedere a Napoleone il gran bottino: i tentativi di nascondere la stele si rivelarono inutili e così la nostra lastra trovò casa, già dal 1802, nelle meravigliose stanze del British Museum, dove tuttora riposa serena.
Una dedica speciale
Peccato (o per fortuna!) che il medesimo testo fosse riportato in 3 differenti scritture: greco antico, demotico e geroglifico. E qui inizia il bello!
“Ce l’ho fatta!”
La fortunata eccezionalità della stele di Rosetta risiede in gran parte qui: se il contenuto riportato nei tre diversi linguaggi (tra cui, per l’appunto, i geroglifici), era lo stesso, si poteva dare il via alla decifrazione!
La decodifica assunse a tutti gli effetti le sembianze di una sfida internazionale: carta e penna alla mano, eruditi provenienti dall’intera l’Europa si cimentarono nell’impresa.
Inutile negarlo, Francia e Inghilterra la fecero da padroni.
Il britannico Thomas Young scelse di sfruttare le sue competenze scientifiche affrontando l’enigma come un problema matematico: una volta ottenuta la traduzione dal greco, procedette a confrontare il risultato associandovi i geroglifici. Trovò così, tra la moltitudine di segni sconosciuti, il nome di Tolomeo V Epifane. Ed ecco qualche primo, timido, passo avanti.
Ahinoi, la storia parla da sè: il nostro Thomas non poteva ancora saper che il suo acerrimo rivale in questa sfida all’ultima traduzione, il francese Jean-François Champollion, sarebbe poi passato alla storia come il padre dell’egittologia.
“Je tiens mon affair!” (“Ce l’ho fatta!”). Fu urlando queste parole, o almeno così narra la leggenda, che Champollion si precipitò dal fratello per annunciare la scoperta. Partendo dalle intuizioni di Young, che come abbiamo detto era riuscito ad individuare il nome di Tolomeo V Epifane, Champollion decifrò anche il nome di Cleopatra I. A questo punto procedette a logica: se i due sovrani erano stranieri, era altamente probabile i loro nomi fossero scritti esattamente come si pronunciavano.
Il gioco era ormai fatto. Il nostro eroe aveva intuito il doppio valore (fonetico e ideografico) dei geroglifici antichi e, notando che i nomi dei regnanti avevano dei segni in comune, iniziò a confrontarli con il demotico e con il greco.
La Lettre à M. Dacier fece il resto: il 27 settembre del 1822, dopo ormai 4 anni di studio matto e disperatissimo, Champollion annunciava alla comunità scientifica (e al mondo) di aver tradotto i geroglifici.